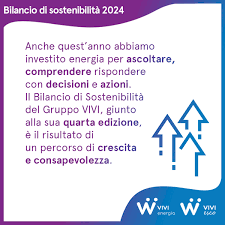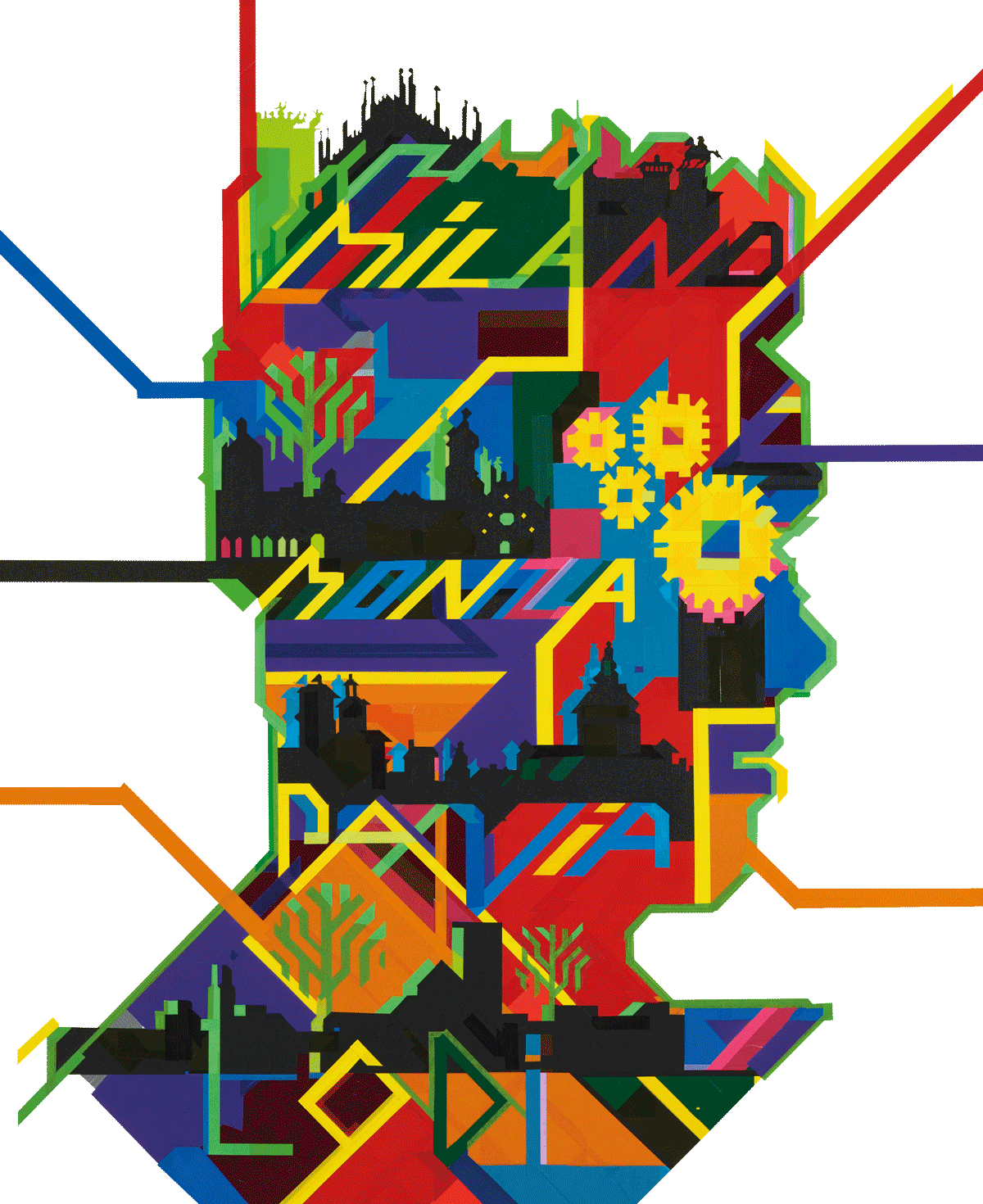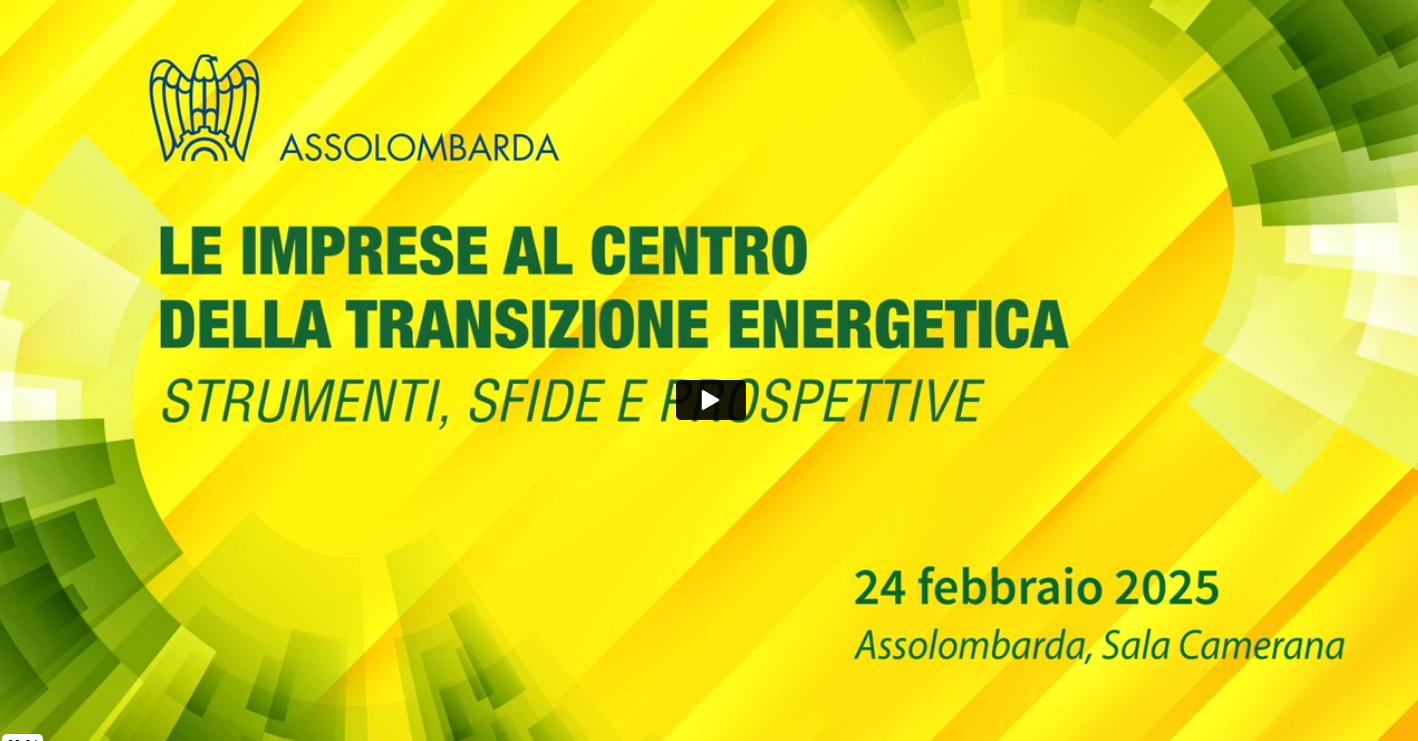C’è un momento, durante una camminata in un parco nazionale, in cui lo sguardo si allunga all’orizzonte e ci aspettiamo di riconoscere le linee nette di una montagna, l’arco di un lago, la trama dei boschi in lontananza. Ma quando quei contorni si fanno sfocati, opachi, quasi disciolti nell’aria, non è solo un’impressione poetica: è scienza. Ed è esattamente da questa evidenza che nasce “Visibility”, il progetto che sta trasformando la visibilità atmosferica in un indicatore concreto dell’impatto dell’inquinamento nei parchi nazionali italiani.
A guidarlo è il CUFAA, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, insieme a ENEA, che analizza i campioni raccolti sul campo. Il cuore del progetto è una tecnologia che sembra uscita da un centro di ricerca statunitense – e infatti lo è: l’IMPROVE, metodologia adottata dalla US Environmental Protection Agency, qui applicata per la prima volta in Europa. Il procedimento è tanto rigoroso quanto innovativo: una centralina installata nel Parco Nazionale del Circeo, nei pressi del lago dei Monaci, cattura ogni tre giorni campioni d’aria per 24 ore, misurando PM2.5 e PM10, solfati, nitrati, biossido di azoto e altri inquinanti. A questi dati si affiancano una telecamera panoramica, sensori meteo e analizzatori per gas inquinanti.
Il risultato è un algoritmo, sviluppato dalla Colorado State University, che restituisce l’indice di attenuazione luminosa: un coefficiente capace di dire, numeri alla mano, quanto la qualità dell’aria renda meno nitido il paesaggio. Aumenta l’indice? Diminuisce la visibilità. Una relazione diretta, quasi brutale nella sua semplicità, confermata dai primi risultati.
Dietro questa riduzione ci sono cause molteplici. Quelle umane: traffico – anche portuale –, combustione da attività domestiche, agricole, industriali. E quelle naturali: il trasporto di materiale terrigeno, tipico di determinate condizioni atmosferiche e geografiche. Ma soprattutto un ruolo cruciale è giocato dagli inquinanti “secondari”, come ammonio nitrato e ammonio solfato, non emessi direttamente ma generati da reazioni chimiche successive nell’atmosfera. Un nemico invisibile che lavora in silenzio, stringendo la morsa sulla nostra capacità di vedere lontano.
Dal Circeo, il progetto si è spostato verso le montagne, nella Riserva Naturale di Vincheto di Celarda, nel Parco Nazionale delle Dolomiti bellunesi. Un ecosistema completamente diverso, più umido e prealpino. Qui, la metodologia ha superato un banco di prova fondamentale: adattarsi alle condizioni ambientali variabili, mantenendo precisione e affidabilità.
Ma “Visibility” non è solo un esercizio tecnico. È un tassello strategico del più ampio progetto europeo LIFE MODERn(NEC), che punta a rispettare gli obblighi di riduzione delle emissioni e a monitorare gli impatti dell’inquinamento su foreste e acque dolci. In altre parole: dare sostanza alle norme europee, trasformando gli obiettivi in strumenti operativi reali.
La posta in gioco è alta. Non riguarda soltanto la tutela del paesaggio – pure fondamentale –, ma la capacità di dotare istituzioni, scienziati e cittadini di un indicatore immediato, leggibile e universale. Perché misurare quanto vediamo significa misurare quanto stiamo perdendo. E comprendere quanto dobbiamo ancora fare per restituire ai nostri parchi la nitidezza che meritano.